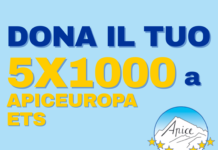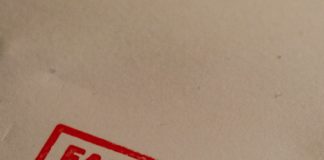Ormai è chiaro per tutti che la legge italiana di bilancio per il 2024 rischia di essere pallida, quasi esangue. Il governo lo anticipato con franchezza: i soldi sono pochi, i bisogni molti e le promesse della scorsa campagna elettorale ancora più numerose e toccherà scordarsene.
La legge di bilancio 2023 era una fotocopia appena ritoccata di quella che stava preparando il governo Draghi e alla quale l’Unione Europea guardava con comprensione. Adesso il governo è cambiato, non lo guida più l’ex presidente della Banca centrale europea e l’andamento dell’economia europea e italiana non manda buone notizie, con un intreccio che penalizza in particolare Germania e Italia, a rischio recessione la prima e la seconda con la crescita rallentata rispetto alle previsioni.
Non stupisce che in questo scenario la legge di bilancio si colori d’Europa, con l’Italia che da una parte si aspetta comprensione dall’UE e, dall’altra, spera nei suoi contributi miliardari, da mesi attesi per il “Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR).
La comprensione si riferisce al margine di flessibilità consentiti dal Patto di stabilità che sarà in vigore l’anno prossimo quando avrà fine la sua sospensione decisa nella primavera del 2020. Una partita che per ora si gioca al buio per i negoziati in corso che vedono contrapporsi i Paesi rigoristi del nord, Germania e Olanda in testa ma non solo, e i Paesi del sud che chiedono flessibilità e misure meno severe per il rientro dal debito. L’Italia può sperare nella mediazione della Commissione europea che apre alla possibilità di spalmare in un periodo di sette anni il rientro dal nostro enorme debito pubblico (circa 1800 miliardi di euro) senza rate annuali insostenibili che si mangerebbero gran parte delle risorse finanziarie italiane, dosando il ritmo della riduzione del debito.
A tutto questo si aggiunge la richiesta italiana di consentire di non contabilizzare come spesa pubblica nel calcolo dei parametri europei i costi sostenuti per la solidarietà all’Ucraina e gli interventi a salvaguardia dell’ambiente.
La speranza di rinsanguare le casse dello Stato allo stremo di liquidità molto dipende dai versamenti europei per il PNRR. Una rata di 18,5 miliardi di euro, attesa da marzo e annunciata da mesi come imminente potrebbe, se tutto va bene, essere versata ad ottobre. Più incerti i tempi per incassare la rata successiva di 16,5 miliardi, prevista nell’estate e forse in arrivo per fine anno. I ritardi non sono dovuti a eccessi di burocrazia, ma all’insufficiente stato di realizzazione del PNRR, tanto per quanto riguarda le spese (appena il 13,4% dei 191 miliardi disponibili) e gli investimenti effettuati che per le riforme concordate con l’UE. Su entrambi i versanti l’Italia viaggia con grande ritardo, adesso aggravato da una richiesta di profonda revisione del PNRR presentata a Bruxelles ad agosto e che non potrà ricevere una risposta definitiva in tempi brevi.
Difficile anche prevedere come coloreranno la legge di bilancio le future decisioni della Banca centrale europea, la cui politica monetaria punta a raffreddare l’inflazione ma raffredda anche la crescita e fa lievitare gli interessi che l’Italia deve pagare per il suo debito pubblico, un gruzzolo ragguardevole stimato attorno agli 80 miliardi di euro l’anno.
E non semplifica nulla, anche se qualche finestra di opportunità può offrirla, la vigilia elettorale europea che potrebbe consentire maggiori flessibilità per i bilanci pubblici dei Paesi UE. Ci sperano soprattutto Paesi come la Francia, la Spagna e la Grecia, quest’ultima non a caso sollecitata per un’alleanza dal governo italiano, anche se è chiaro a tutti che sarebbero di gran lunga più efficaci le alleanze con Parigi e Madrid, non proprio vicine politicamente all’Italia come Atene.