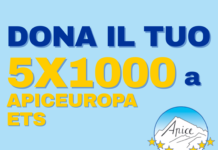Le elezioni europee del maggio 2019 avevano segnato una svolta importante per l’Unione Europea.
Era aumentata, anche se non di molto, la partecipazione al voto e l’esito elettorale aveva premiato le forze politiche orientate in favore di un rafforzamento del processo di integrazione europea. Al timone delle Istituzioni comunitarie erano salite due donne, la tedesca Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione e la francese Christine Lagarde alla guida della Banca centrale europea, mentre prendeva, non senza qualche sorpresa, la presidenza del Parlamento un italiano del Gruppo socialista, David Sassoli, che si sarebbe rivelato un inatteso protagonista politico, purtroppo mancato troppo presto in corso di mandato. Più modesta la figura del liberale belga Charles Michel alla presidenza del Consiglio europeo, un ruolo che avrebbe potuto essere interpretato con maggiore vigore ma che non ha più di tanto indebolito la squadra di vertice.
A provocare tempestivamente un’accelerazione del processo di integrazione era stata la presidente della Commissione, forte del sostegno della coppia franco-tedesca che l’aveva proposta e dell’esperienza che Ursula von der Leyen portava dal suo passato di ministra federale, prima della famiglia e poi della difesa.
Poco tempo dopo il suo insediamento, nel dicembre del 2019, veniva lanciato il “Green deal” (Piano verde), un ambizioso programma di misure per accelerare una transizione ambientale da realizzare con scadenze impegnative e ravvicinate nel tempo che proiettava l’UE all’avanguardia nel mondo per la salvaguardia di questo nostro Pianeta malato.
Va detto subito che la congiuntura storica non è stata favorevole: nel 2020 l’UE è travolta dalla pandemia da Covid, a cui però le Istituzioni comunitarie reagiscono rapidamente e con efficacia, tanto sul piano sanitario che su quello economico, ma le conseguenze si faranno sentire a lungo. Come se non bastasse due guerre irrompono ai confini dell’UE: il 24 febbraio 2022 la Russia invade l’Ucraina e a ottobre 2023 esplode il conflitto israelo-palestinese. Cambia radicalmente il quadro geopolitico, pesa la crisi energetica, si impenna l’inflazione e la crescita economica rallenta fino a spegnersi in alcuni Paesi, come oggi in Germania. Pesano anche flussi migratori inarrestabili e non governati, né a livello nazionale né a quello europeo.
Gli obiettivi della transizione verde ne risentono, a molti i costi sembrano insostenibili, i governi esitano a mantenere il ritmo, timorosi di perdere consenso, un settore elettoralmente importante come quello dell’agricoltura si ribella, imputando alla transizione ambientale promossa dall’UE responsabilità non tutte sue. In questo clima non aiuta la vigilia elettorale, occasione da non perdere per alzare il tono delle proteste, fino ad inaccettabili livelli di violenza, come avvenuto a Bruxelles.
In tale contesto, Ursula von der Leyen, anch’essa in campagna elettorale per ottenere un rinnovo del suo mandato, tiene il punto sulla solidarietà all’Ucraina ma sbanda a più riprese su dossier delicati: è il caso del sostegno alle politiche di esternalizzazione dei flussi migratori sostenuta dalle forze di destra, come nel caso italiano in Tunisia e poi in Albania; prosegue con prese di posizioni poco equilibrate nella vicenda israelo-palestinese e cede rapidamente alle proteste degli agricoltori derogando a misure prese, come sui terreni a riposo, o in programma, come la riduzione dei pesticidi in agricoltura, riducendo la protezione del pianeta ed esponendo gli europei a gravi rischi sanitari.
Sta finendo con una traiettoria calante la spinta che Ursula von der Leyen aveva meritoriamente cercato di imprimere alle politiche europee: toccherà adesso alla consultazione elettorale valutare questa evoluzione e dire quale nuova Europa mettere in cantiere e con quali nuove guide per le Istituzioni comunitarie.