Non è la prima volta che il Consiglio europeo dei Capi di Stato e di governo ha occasione di confrontarsi sul futuro dell’UE dopo l’esplosione della pandemia e non sarà nemmeno l’ultima. Il 26 marzo scorso fu l’occasione per un duro contrasto tra l’Italia, a nome anche degli altri Paesi dell’Europa meridionale, e l’Olanda, alla testa dei cosiddetti Paesi “frugali” e rigoristi.
Il confronto di venerdì scorso, pur non giungendo ancora a conclusioni operative rinviate per ora a luglio, ha segnato una svolta, in risposta a quella impressa, in parte a sorpresa, dalla proposta della Commissione europea con il suo “Piano per la ripresa”. Una svolta c’è stata nei toni, in particolare tra Italia e Olanda (meno con l’Austria), ma soprattutto nel merito per l’adesione di tutti alla necessità di un intervento straordinario, salvo discuterne i singoli elementi.
E’ normale che al momento l’attenzione si concentri sul volume imponente di risorse proposte dalla Commissione, tra contributi e prestiti, e sulle dimensioni del futuro bilancio 2021-2027 e non sorprende l’insistenza di molti Paesi per ridurre quanto proposto dalla Commissione. Fa parte del gioco, con le Istituzioni a tendenza federale (come Commissione e Parlamento europeo, ma anche BCE) scontrarsi con i governi nazionali, poco propensi ad allargare i cordoni della borsa per contribuire al bilancio comune e spesso molto affamati delle “provvidenze” europee. Senza contare le variabili temporali di esecuzione del piano che stanno particolarmente a cuore all’Italia e il gioco in corso, da parte dei “frugali”, di mettere in salvo i rimborsi di bilancio conquistati negli scorsi esercizi finanziari.
A questo proposito sembra disegnarsi un triangolo politico con un lato corto più robusto, ma particolarmente forte, come quello franco-tedesco, e due più lunghi e più fragili: da una parte i Paesi meridionali UE, maggiormente colpiti dalla pandemia e destinatari naturalmente prioritari delle risorse disponibili e, dall’altra, i Paesi dell’Europa centro-orientale finora foraggiati generosamente dal bilancio UE e adesso preoccupati di fare le spese delle nuove priorità. E’ ormai nei fatti che il “luogo geometrico” di equilibrio sarà molto più quello della Germania che non quello della Francia, anche se sarebbe positivo per tutti che questa “coppia sbilanciata” riuscisse a condurre in porto la trattativa.
Al di là della propria forza economica e politica, la Germania ha un’ulteriore opportunità istituzionale, quella di governare da luglio a dicembre la presidenza semestrale dell’UE e quindi anche la possibilità di orientare un confronto che si annuncia difficile, non solo per il volume di risorse da reperire e ridistribuire, ma anche per le novità politiche che potrebbero annunciare gli sviluppi, anche istituzionali, dell’Unione di domani.
La proposta della Commissione apre un varco verso una politica fiscale integrata a livello europeo, destinata per un verso a fare convergere nuove risorse nel bilancio UE, oltre a quelle di provenienza nazionale (oggi rappresentano i due terzi delle entrate) e, per un altro, a incidere significativamente sulle priorità politiche degli Stati membri: nei due casi con una progressiva riduzione delle sovranità nazionali in materia di politica di bilancio.
Niente di totalmente nuovo per chi ha a mente la procedura ormai consolidata del “semestre europeo” che consente al Consiglio UE, su proposta della Commissione, di orientare le priorità dei singoli Paesi su base di “raccomandazioni” già abbastanza dettagliate: chiamatele, se volete, “condizioni”.
Al Consiglio europeo dei giorni scorsi decisioni, per di più all’unanimità, non erano in programma. Che però è stato rispettato negli orientamenti emersi: le risorse saranno probabilmente meno di quelle proposte, con un diverso equilibrio tra prestiti e contributi, forse modificati in favore dei primi e con tempi ancora da definire. A chi avesse pensato al “prendi i soldi e scappa” meglio ricordare che i soldi dell’UE non arriveranno “tutti e subito”.



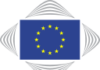










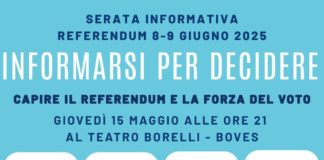
Per quello che riesco a capire mi sembra a buon punto la trattativa in merito al patto UE per uscire dalla crisi ed è consolante vedere che i cofondatori Francia e Germania tengano le fila del discorso pur con le deverse peculiarità. Probabilmente è come sottolineato un passo in avanti verso una politica fiscale integrata che negli sviluppi non potrà che passare attraverso una maggiore maturità degli stati membri, i quali, rinunciando ciascuno a una piccola parte di autonomia fiscale poi reinvestita federalmente non potrà che sfociare gradualmente in una vera e propri federazione di stati all’altezza di competere a livello mondiale.
Certo il cammino è lungo per arrivare ad una legislazione europea atta a garantire la stabilità di questi passi, auspicando non siano sempre e solo le emergenze spingere alla maturità ma bensì le scelte poloitiche di popoli lungimiranti ben rappresentati politicamente.