Oltre settant’anni fa tutto era già chiaro per l’Europa. Basta leggere l’apertura della “Dichiarazione Schuman” del 9 maggio 1950: “La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano. Il contributo che l’Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche”, ricordando che in passato “l’Europa non è stata fatta: abbiamo avuto la guerra”.
Parole scritte nero su bianco poco meno di un anno dalla nascita della NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico) creata con l’obiettivo della difesa collettiva, sancita dall’art. 5, e per creare uno spirito di solidarietà all’interno dell’Alleanza. Sottoscrissero l’accordo nel 1949 dodici Paesi, tra questi l’Italia; solo nel 1955 la Germania, la Turchia tre anni prima; oggi i membri sono 30 e in gran parte vi si trovano i Paesi UE, solo sei non vi partecipano (tra questi Austria, Irlanda e Svezia). E già questa lista racconta di una presenza frammentata dell’UE nella Nato, cui vanno aggiunti gli Stati Uniti che della NATO sono l’azionista principale, che ha rappresentato nella coalizione in Afghanistan l’85% delle presenze.
In questo quadro politico molto complesso, la costruzione di un’Europa “organizzata” in favore della pace non ha avuto vita facile, in particolare dopo il fallimento, nel 1954 ad opera della Francia, del Trattato della “Comunità europea della difesa” e nel contesto di una “guerra fredda”, durata fino al crollo del Muro di Berlino nel 1989, per riprendere con tensioni crescenti a inizio 2000. Nel frattempo l’Unione Europea fece qualche passo avanti sulla strada di una politica estera e di difesa comune, conclusasi per ora con l’entrata in vigore a fine 2009 del Trattato di Lisbona. Vi si trovano, al Titolo V, gli articoli 21- 46 dedicati al tema, densi di generose ambizioni, ma con regole così vincolanti – tra cui la necessità di un consenso unanime – che non si sono visti grandi risultati, come bene ha anche dimostrato la vicenda afghana, con la presenza di alcuni Paesi dell’Unione Europea del tutto marginale, mortificati dal protagonismo USA, soliti a fare e disfare sui campi di battaglia.
Ma anche gli schiaffi possono servire, almeno a risvegliare la “bella addormentata nel bosco” e a suscitare una qualche reazione che ne provi l’esistenza e l’utilità.
All’indomani della disfatta occidentale a Kabul sono tornate a levarsi le voci di quanti – come Paolo Gentiloni – si chiedono “se non ora, quando?”, con la speranza che si riapra un dossier rimasto troppo tempo nei cassetti di Bruxelles, almeno con l’obiettivo di sviluppare una “autonomia strategica” dell’Europa all’interno della NATO, visto anche – come ebbe occasione di dire Emmanuel Macron – il suo “stato comatoso”, senza dimenticare Trump che parlò di un’alleanza “obsoleta”, mettendo contemporaneamente l’Europa in allarme davanti agli USA determinati a “tornare a casa”, come avrebbe poi eseguito puntualmente Joe Biden dall’Afghanistan.
Ma a una domanda non sai sfugge: è questa Unione Europea a 27 in grado di svoltare verso una politica estera e di difesa comune? Meglio rispondere con cautela, in particolare dopo l’uscita dall’UE di un importante alleato militare con il Regno Unito e alla vigilia di due importanti appuntamenti elettorali, in Germania e Francia, dall’esito incerto e con i persistenti e diffusi movimenti nazional-sovranisti in molti Paesi UE che ostacolano la nascita di una sovranità europea, condizione necessaria per raggiungere l’obiettivo.
E’ suonato puntuale il recente monito del Presidente Mattarella, a conferma della Dichiarazione Schuman del 1950: “Da qui nasce l’esigenza di potenziare la sovranità comunitaria che sola può integrare e rendere non illusorie le sovranità nazionali. La sovranità comunitaria è un atto di responsabilità verso i cittadini e di fronte a un mondo globale che ha bisogno della civiltà dell’Europa e del suo ruolo di cooperazione e di pace”.












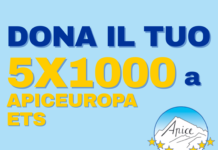



I nodi sono pochi ma molto impegnativi:
1 trattare con paesi matiri,che mettono prima il bene comune
2.i costi sono enormi e senza interessi diretti è difficile trattare